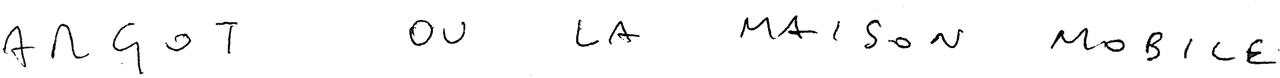A BANK IN LENO
Leno (BS), IT_2012







A BANK IN LENO
Più che una banca, mi ricordava la sede di una di quelle strutture mediche in cui vengono studiati virus ormai debellati da anni. In cui, durante un attacco zombie, la sparuta combriccola di sopravvissuti si dirige alla ricerca disperata di un vaccino.
Io la usavo per puro Freestyle. La pavimentazione e l’inclinazione dei muretti che contenevano le aiuole erano l’ideale per le mie acrobazie.
Le lunghe vetrate riflettevano gli alberi e le case d’intorno, e mi specchiavano mentre saltavo. Vedersi volare dà una certa soddisfazione. Potevo inoltre correggere i miei difetti e la postura della bici, fino ad eseguire delle figure perfette.
Dopo giorni passati ad esercitarmi attorno all’edificio, mi resi conto della totale assenza del tipico via vai che in genere si trova accanto a banche ed uffici.
Nessuno era entrato, nessuno era uscito, E quando provai a spingere le porte le trovai sigillate. Le auto che sostavano nel parcheggio sembravano abbandonate ormai da anni, con spessi disegni incrostati nei finestrini, ormai resi opachi dalla polvere.
Cosa poteva esserci dentro, davvero una banca? Davvero c’erano delle persone che se ne andavano in giro, piene di fascicoli, su e giù per corridoi geometrici, ad eseguire transizioni, spostare denaro, elargire prestiti. E se veramente fosse stato così, chi erano i clienti? Da dove arrivavano? Non avevo mai incrociato le loro macchine, i loro passi, i loro sguardi, ne tantomeno i loro sorrisi. Sorrisi che probabilmente non mi avrebbero fatto, vedendomi saltare su e giù per l’istituzione a cui avevano affidato tutti i loro risparmi.
Incuriosito, ad ogni salto tendevo lo sguardo oltre il mio riflesso, tentando di scorgere più in la, dietro la mia sagoma, un qualcosa che si muovesse dietro le grandi vetrate.
E ogni volta che un piccione volava o le foglie di un albero mosse dal vento si riflettevano nelle lunghe finestre, i miei occhi si spostavano veloci, accaniti, credendo d’aver colto un movimento provenire dall’interno.
Ero sicuro ci fossero delle persone li dentro, altrimenti perché costruire un edificio del genere, perché irrompere con uno scorcio di futuro nel cuore di una cittadina tranquilla, per poi lasciarlo vuoto, colmato solo di riflessi.
Quei riflessi non rimandavano le immagini con i loro colori naturali ma li riempivano di una sfumatura bluastra, e mi pareva come di correre e saltare su di un mondo in cui non era un sole giallo e denso a bruciare nel cielo, ma una stella più smilza ed azzurra. E in quel mondo aldilà del nostro tutto appariva più morbido e poetico.
A volte, forse in corrispondenza di vacanze scolastiche, o per l’improvvisa malattia di un catechista, la piazzetta si riempiva di bambini. Disegnavano con dei grossi gessi colorati sul pavimento. C’era chi s’arrischiava a riprodurre la banca, e nelle piccole vetrate riprodotte dai bambini si potevano scorgere gli alberi e le case riflesse. Visto che la pavimentazione era dello stesso colore dell’edificio, per disegnarlo coloravano direttamente il cielo tutto intorno, ed era quell’azzurro a definire i confini dell’architettura.
Si divertivano ad osservare gli eco delle loro immagini muoversi blu nelle vetrate. E anche le loro mamme amavano specchiarsi, ma in maniera più attenta, nascondendo il piacere che provavano, per non lasciar trasparire il sottile narcisismo che nei figli era ancora giocoso. Si sistemavano i vestiti, spostavano un ciuffo di di capelli dagli occhi, e guardavano i bimbi nello specchio, così che anche se rivolgevano l’attenzione a loro stesse, con la coda dell’occhio potevano controllarli.
Un giorno, mentre spiccavo un salto al limite delle mie capacità, tendendomi all’impossibile, fino a sentire le articolazioni separarsi, per portare la bici ancora più in alto, allungando a più non posso ogni muscolo e tendine e contorcendo la bocca in una smorfia ambiziosa, la vidi.
Non furono più di tre o quattro secondi, ma durante il volo ogni cosa rallenta, e come ho già detto, il mondo, riflesso in quelle vetrate, si acquietava, come si trattasse d’una dimensione parallela in cui i secondi si dilatano nel tempo, si susseguono con sforzo. Per questo quei pochi attimi mi permisero di cogliere le emozioni della ragazza sfogliarsi nitide sul suo volto.
Prima nella bocca vidi uno stupore caricarsi, nascere dagli angoli della bocca e vibrare fino al centro delle labbra, portandole a schiudersi in un morbido ovale di stupore, in cui i sottili lembi ai lati erano rimasti leggermente appiccicati, forse perché da molto non si schiudevano a quel modo. Poi quel fremito si versò come un riverbero nelle guance e le riempi per un istante di un rossore che risaltò con forza sul volto sfumato d’azzurro, ma subito svanì anch’esso per diventare gioia sottile negli occhi, che si spremevano tentando di ombreggiare le pupille, dove il sole si insinuava, forse per la prima volta da moltissimo tempo. Ma quando le sopracciglia si incresparono in quel movimento di difesa, tutto lo stupore sembrò ripercuotersi sul volto in caduta libera, sorvolando la sua espressione d’un terrore palpabile. Gli occhi si aprirono, si tesero, il naso si fece acuminato e la bocca tornò a serrarsi come risucchiata verso i denti da un grido che si rivolgeva all’interno.
Scomparve in un attimo, come trascinata da mani invisibili che non potevo vedere.
Attesi fino al tramonto con la speranza di rivederla.
Lentamente la luce del giorno scomparve, ed anche il sole freddo che dominava quel mondo distante sembrò tramontare. I lampioni si accesero e l’edificio mi apparve come un imponente monolite nero, pregno solamente di se stesso.
Ma quando le luci al suo interno s’innescarono, in quella concatenazione vibrante tipica del neon, potei con lo sguardo sondarne il ventre, riuscii a sondarne il ventre con lo sguardo, che appariva curiosamente vuoto, come se avessero dimenticato di completarlo con stanze e corridoi.
Decine di persone stavano in piedi davanti alle grandi vetrate, immobili, con le braccia a penzoloni. Sembravano osservare l’orizzonte oltre le case, con il corpo sfuggevole e lo sguardo fisso di chi è distratto all’interno di un estrema concentrazione.
Alzai una mano in un gesto di saluto ma non ricevetti risposta. Le tirai su entrambe, agitandole, perché volevo che mi vedessero. Avevo atteso così a lungo, fantasticando su cosa facessero quelle persone, che ora non potevo lasciami sfuggire l’occasione di comunicare con loro.
Ma il mio sbracato agitarmi non servì a nulla e le mie dita tese non attirarono la loro attenzione, perché quelle persone non potevano vedermi, si stavano specchiando. Stavano osservando il loro stesso riflesso.
Non potevano vedere all’esterno, il vetro non glielo permetteva. Come durante il giorno l’edificio non consentiva d’essere penetrato con lo sguardo dall’esterno, durante la notte privava i suoi abitanti della vista del mondo di fuori.
Rividi la ragazza che avevo intravisto il pomeriggio, fissava dritto davanti a se, e quando i nostri sguardi si incrociarono, riuscii a vederle nel riverbero delle pupille la sua stessa immagine riflessa. Era anche lei nello stesso stato apatico delle altre persone, e quel bagliore che le avevo visto sul volto qualche ora prima era ormai scomparso.
Quando all’alba mi avvicinai, fino a sfiorare il vetro con le ciglia, per esaminare quella gente l’ultima volta, prima che sparisse di nuovo, le luci si spensero d’improvviso e mi ritrovai agghiacciato di fronte al mio stesso gelido riflesso.
In quel momento compresi il mistero di quelle persone.
Avevano scorto nel fondo della loro pupilla, come nel fondo di un pozzo, quel rimasuglio di fango che il sole non riesce mai a scorgere, quel luogo remoto dell’anima dall’odore di posacenere e ferro, il retrogusto peccaminoso dell’esistenza.
E non si erano più potute muovere.
Egon Ustino
***
Location: Leno, BS (IT)
Client: Cassa Padana Credito Cooperativo
Architecture:
Luca Abbadati, Luca Astorri, Matteo Umberto Poli
Photo:
Filippo Poli
Date:
2012